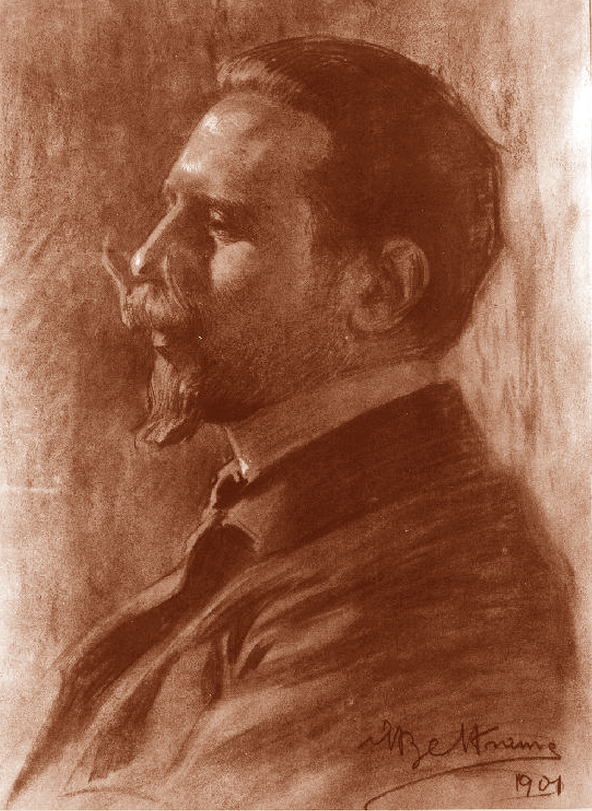Nel dolce autunno del 1924 il pittore parmigiano Daniele De Strobel (1873-1942) ci accoglie nella villa che si è fatto costruire a poca distanza da quella paterna a Vignale vicino a Traversetolo. Dopo averci fatto ammirare il suo purosangue Lampo, il cavallo con cui è solito recarsi a Parma per far lezione all’Istituto di Belle Arti, ci accompagna nel giardino dove ci attendono lo scenografo parmigiano Giuseppe Carmignani (1871-1943) e il presidente della Camera di Commercio di Parma Romano Righi Riva (1873-1956). Oggetto dell’incontro sono i grandi pannelli murali ad olio che devono decorare la Sala del Consiglio della nuova sede della Camera di Commercio e per noi l’occasione di interviste per meglio conoscere queste importanti opere pittoriche.
Ingegner Righi, nella ristrutturazione dell’edificio dalle forme neorinascimentali e liberty che diventerà sede della Camera di Commercio di Parma è prevista una sala del Consiglio. Perché e con quali finalità ne è stata affidata la decorazione al pittore Daniele de Strobel e allo scenografo Giuseppe Carmignani?
Come nuova sede della Camera di Commercio è stato scelto un palazzo d’antica origine, già sede dell’Università farnesiana e poi di proprietà comunale, che l’architetto Alfredo Provinciali (1867- 1929) con il contributo di ingegneri e del pittore e architetto Ennio Mora (1885-1968) stanno trasformando mantenendone le caratteristiche salienti, mentre il pittore parmigiano Paolo Baratta (1874-1940) è stato incaricato di affrescare la fascia di coronamento delle facciate esterne dell’edificio con l’allegoria del Commercio. In questo ambito io con il Consiglio della Camera riteniamo che il luogo dove saranno discusse e prese importanti decisioni per il commercio parmigiano debba ricordare agli amministratori le nostre radici, i commerci e al tempo stesso la nostra appartenenza ad un nuovo Stato unitario, in una specie di scenario che copra le pareti della sala. In questo periodo a Parma stanno cambiando i tradizionali equilibri della società rurale con una nuova imprenditoria agraria che usa innovazioni tecniche; in diversi settori si sta sviluppando l’industrializzazione, vediamo affermarsi il ruolo dei tecnici agrari e di una innovazione tecnico-culturale e sempre maggiori sono i legami dell’agricoltura col credito. Numerosissime sono oggi le industrie importanti di Parma con mulini, pastifici, fabbriche di concimi, fornaci, fabbriche di profumi, centrali elettriche, calzaturifici e altre attività che continuamente accrescono la ricchezza della nostra provincia e che si affiancano all’industria delle conserve alimentari nelle quali eccellono quelle del Formaggio Parmigiano e del pomodoro. Da qui le indicazioni date agli artisti assegnatari dell’opera, due parmigiani, uno pittore e l’altro scenografo, entrambi di chiara fama che ben conosciamo, qui presenti e che meglio di me possono descrivere il lavoro.
Maestro Carmignani, lei ai parmigiani è noto come professore di ornato e insegnante scenografia nell’Istituto di Belle Arti di Parma e per l’allestimento delle scene per le opere teatrali di Aida e Ballo in Maschera per il Teatro Regio di Parma. Ora stiano parlando della decorazione di una sala di un Consiglio e quale è qui il suo ruolo di scenografo?
Forse lei dimentica molte altre mie esperienze in Italia e soprattutto in America Latina, ma per rispondere alla sua domanda le dico del mio ruolo. A lungo ne abbiamo discusso a diversi livelli, in particolare con l’ingegnere Righi e soprattutto con il collega De Strobel. A parte i miei interventi pittorici d’ornato, il mio contributo di scenografo mira a trasformare una sala del consiglio decorata con semplici riquadri in una specie di anfiteatro con un grande scenario d’immagini che documentino e richiamino i principali caratteri, soprattutto agricoli tradizionali, dell’attuale commercio parmigiano, usando un moderno linguaggio espressivo e soprattutto comunicativo, come siamo sempre più abituati a vedere e apprezzare in un teatro, e di cui il mio collega De Strobel è maestro. Una rappresentazione che sottolinei inoltre la continuità tradizionale che caratterizza lo sviluppo delle produzioni e dei commerci agricoli parmigiani, di cui sono indubbia e bella dimostrazione il formaggio Parmigiano e l’industria del Pomodoro.
Maestro De Strobel, dai quadri ad una scenografia di ampio respiro… Come si trova in questa che credo sia per lei una nuova esperienza pittorica?
Una nuova e stimolante esperienza che ho affrontato e sto risolvendo sula base della mia lunga appartenenza parmigiana ed ampia esperienza nella pittura. Per diversi motivi non ultimo quello dei tempi stringenti (N. d. I. – La sala sarà inaugurata il 4 novembre 1925) non uso l’affresco ma grandi pannelli murali ad olio sui quali posso usare il mio ingegno artistico, lavorando nello studio allestito in questa villa. In questo modo posso dipingere poche ma grandi immagini che saranno ben visibili da ogni parte della sala del Consiglio. Inquadrate da cornici con festoni di foglie e frutta eseguite da Giuseppe Carmignani, in una sequenza narrativa dominata da un cromatismo chiaro e luminoso nelle pareti principali, sulla base di quanto indicato dal Presidente Righi e ora spiegato da Carmignani, sto figurando La raccolta del pomodoro e Il trasporto del latte sulle pareti lunghe, mentre nei due ovali al centro delle pareti corte pongo rispettivamente un Ritratto equestre di Vittorio Emanuele III e una figura di Mercurio a simboleggiare i traffici commerciali.
Gentile Maestro, il latte e la sua trasformazione in formaggio Parmigiano sono un’antica tradizione, mentre più recente è quella del pomodoro: come le sta rappresentando?
Su queste due sequenze narrative che ho dovuto adattare alle pareti della sala del Consiglio molto vi sarebbe da dire. Dopo, nel mio studio, potrò farvi vedere alcuni disegni preparatori, ma posso già descrivere quanto ho già in avanzata fase di attuazione.
Due pannelli rappresentano il trasporto del latte destinato al casello per fare il Formaggio Parmigiano. Il primo mostra l’importanza dell’origine del latte per fare il Parmigiano e raffigura due vacche bianche con decorazioni che richiamano antichi usi sacrali, ricondotte a casa dal mercato da un contadino, il secondo raffigura una casa colonica con un tipico edificio affiancato per servire da caseificio e il motto che commenta la scena recita Nihil est agricoltura melius – Nulla è meglio della pratica agricola.
L’industria del pomodoro è illustrata dal suo inizio ed è suddivisa in quattro pannelli. La prima rappresenta la coltivazione con le piantine di pomodoro tra le quali emerge una pianta di granoturco, la seconda due contadine intente a raccogliere i pomodori, la terza un gruppo di tre figure, una contadina, un giovane contadino e una compagna che con i pomodori raccolti si avviano verso un paese pedecollinare, la quarta scena raffigura due cavalli da tiro bardati con in primo piano una cesta dalla quale si riversa una cascata di pomodori e sullo sfondo l’alta ciminiera fumante di una fabbrica di concentrato del rosso frutto. Una intera catena dal campo alla fabbrica con il motto Non omnis feret omnia tellus commenta queste immagini.
Ingegner Righi Nihil est agricoltura melius e Non omnis feret omnia tellus sono due massime sull’agricoltura che decorano i grandi dipinti ora descritti. Quali le loro origini e i motivi della loro presenza nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Parma?
Vasto, profondo e antico problema riguarda il ruolo e il rapporto tra agricoltura e commerci, di stretta pertinenza per una Camera di Commercio e per una sala dove si devono prendere decisioni in un ambito essenziale per la nostra vita cittadina e al tempo stesso oggi in rapida evolouzione. Sempre mutevoli sono anche i rapporti tra l’agricoltura e i commerci che hanno la massima espressione a metà del XVIII secolo nel dibattito tra le teorie della fisiocrazia e del mercantilismo. Senza entrare in dettagli mi limito a ricordare che la fisiocrazia è una dottrina economica nella quale secondo il pensiero di François Quesnay (1694-1774) l’agricoltura è la vera base di ogni altra attività economica e l’unica in grado di produrre beni, mentre l’industria si limita a trasformare e il commercio a distribuire. Con la fisiocrazia assume un ruolo primario il momento della produzione dei beni e non il momento dello scambio come situazione in cui è creata ricchezza perché tutto il ciclo economico della fisiocrazia crea un prodotto che è poi investito nell’agricoltura per aumentare la produttività di un terreno, avere più manodopera, compiere ricerche nel campo delle coltivazioni. Una concezione di vita che si afferma in Francia verso la metà del XVIII secolo, in opposizione al mercantilismo e da qui Nihil est agricoltura melius. Proprio qui a Parma abbiamo avuto un forte sostenitore della fisiocrazia in Stanislao Solari (1829-1906) che nella villa Il Borgasso di Marore (PR) dedicandosi alla sperimentazione agraria è l’ideatore di un innovativo metodo di coltivazione razionale, basato sulla rotazione delle colture di leguminose, produttrici di azoto, e di cereali, che invece ne abbisognano (azotofissazione). Divulgando i risultati delle sue sperimentazioni attraverso numerose pubblicazioni, Solari, animatore del movimento neofisiocratico cattolico che fa capo alla scuola salesiana di Don Carlo Maria Baratta (1861-1910) fondatore della scuola di agraria di Montechiarugolo, afferma la libertà di diffusione dei beni, reputando la terra unica fonte di ricchezza. Per questo il pensiero fisiocratico con il motto Nihil est agricoltura melius è rappresentato dalle immagini riguardanti il formaggio del Maestro De Strobel.
Ingegner Righi grazie per quanto riguarda Nihil est agricoltura melius, ma per Non omnis feret omnia tellus?
“Omnis feret omnia tellus” – “Ogni terra porterà tutti i frutti” è una citazione tratta dalla quarta Egloga delle Bucoliche del grande poeta latino Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.), e fa parte della descrizione utopica di una futura e autarchica Età dell’Oro, in cui la terra produrrà ogni cosa, rendendo inutili gli scambi commerciali. Nella nostra sala, invece, la frase è rovesciata dalla negazione iniziale, che sottolinea il ruolo della specializzazione dei distretti e dell’attività mercantile per la diffusione delle merci.
Peraltro la versione negativa del verso virgiliano si riscontra in numerosi testi italiani di economia politica pubblicati a cavallo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e rimanda alla teoria economica del mercantilismo.
Il mercantilismo, al quale ho già accennato, è la politica economica prevalente in Europa dal XVI al XVII secolo, basata sul concetto che la potenza di una nazione è accresciuta dalla prevalenza delle esportazioni sulle importazioni e in termini economici di uso comune, si parla di surplus commerciale e trova differenti politiche a seconda della specializzazione economica naturale (agricola, manifatturiera, commerciale) e all’idea di ricchezza (oro, popolazione, bilancia commerciale).
A Parma non abbiamo nessuna personalità di spicco di questa corrente, ma molti interessi che riguardano le sue diverse produzioni agricole e animali, coinvolgendo da sempre anche il nostro formaggio e in tempi più vicini ricordo la monografia Saggio intorno alla Fabbricazione del Cacio detto Parmigiano (1808) di Giuseppe Bayle-Barelle (1768-1811) Professore di Agricoltura nella Università di Pavia. Negli attuali tempi vi è poi l’industria delle conserve di pomodoro e la commercializzatine dei suoi prodotti. Che non vi sia solo la produzione agricola e non anche dalla trasformazione e commercio dei suoi prodotti è a Parma una scelta antica, quando nella Roma di Marco Valerio Marziale (38-104 d.C.) Parma Tondet et innumeros Gallica Parma greges Parma, nella Gallia cisalpina, tosa innumerevoli armenti (Epigrammi, V, 13, 8) divenendo famosa per le sue lane prodotte dalle greggi di pecore di Callistrato, Candido ed Afro, che a quest’ultimo rendono ogni anno seicentomila sesterzi (N. d. I. – Non dimenticando le placchette di piombo per marcare le balle di lana ritrovate nel 2010 sotto l’odierna Piazza Ghiaia). Sempre nella Parma romana, dai suini si ottengono pernae e petasones (prosciutti e spalle salate) esportate per gli eserciti dell’Impero e molto probabilmente i caci di pecora che sono imbarcati nel porto di Luni per essere marchiati col sigillo della luna prima di essere spediti a Roma. E non è certamente un caso che i Romani per questi commerci nel territorio parmigiano fondano il Forum Novum (Fornovo) sulla via che la congiunge al Mare Mediterraneo dei commerci. Per lo stesso motivo la prima istituzione di una Camera di Commercio nel Ducato Parmense, collegata alla politica fortemente innovativa perseguita da Guillaume Du Tillot (1711-1774) riguarda le attività manifatturiere e commerciali e solo dopo il 1850 le sono attribuite competenze in materia di agricoltura. (N. d. I. – La Parma agricola dei commerci trova riferimento nei suoi mercati e fiere tradizionali e nel Sistema Fieristico del XX e XXI secolo). Per questo il pensiero mercantilista con il motto Non omnis feret omnia tellus è rappresentato dalle immagini dipinte sulle tele del Maestro De Strobel dove il pomodoro raccolto è trasformato, ovviamente per la esportazione).
Ingegner Righi grazie per quanto mi ha ora precisato, che mi porta a chiederle quale rapporto abbiano a Parma fisiocrazia e mercantilismo.
Da quanto fin qui esposto, le dico che non sono in contraddizione, ma in un fruttuoso confronto dialettico, che deve essere tenuto ben presente da coloro che devono sedere e decidere nella Sala del Consiglio di questa Camera del Commercio.
Maestro De Strobel, Parma ed il suo territorio sono un laboratorio per uno sviluppo in un l’intreccio agro-industriale e per questo le chiedo perché nello scenario che lei sta dipingendo non rappresenta alcuna macchina, ma, ad esempio cavalli da tiro bardati e non un autocarro.
Non voglio entrare in una lunga discussione, conosco bene di come e quando le macchine, e tra queste le automobili, sono entrate non solo nella industria e nella trasformazione agraria ma anche in pittura. Per esempio Giacomo Balla (1871-1958) tra il 1912 e il 1913 dedica oltre cento quadri all’automobile in una nuova religione morale della velocità. Ma per una salvaguardia e uno sviluppo agricolo e soprattutto alimentare parmigiano, ritengo che sia necessario non dimenticare la tradizione, di cui il cavallo è espressione e simbolo.